
“Speriamo che la Nazionale non sia lo specchio della Nazione, altrimenti dovremmo tutti imitare Prandelli & Abete e dimetterci irrevocabilmente da noi stessi”, scriveva stamattina Gramellini nel suo Buongiorno su La Stampa. Stranamente – succede poche mattine all’anno – non sono d’accordo con lui. Perché io oggi, invece, mi sono svegliata esattamente con lo stesso pensiero con cui ero andata a dormire ieri sera, il pensiero di una che di calcio non ne capisce granché ma di società e di sociologia forse qualcosina di più: “Adesso il processo di identificazione tra l’Italia e l’Italietta è completo. Adesso anche una di quelle poche cose che negli anni ci ha reso orgogliosi fuori dai nostri confini, ci somiglia definitivamente”.
Lo so che tra tutti i commenti del day-after questo è un po’ scontato e suona anche un po’ disfattista, ma la verità è che porta in sé una speranza, che suona più o meno così: “Adesso che abbiamo fatto l’unica brutta figura di cui alla maggioranza degli italiani importa davvero qualcosa, forse cominceremo a metterci davvero in discussione per cambiare”.
Perché in qualche possibilità di vittoria ci abbiamo creduto davvero, ci abbiamo creduto dopo la prima partita contro l’Inghilterra, ci abbiamo creduto persino quando ce lo ha pronosticato Mick Jagger dal palco del Circo Massimo – è un po’ nell’animo italiano confidare che un lieto fine, in qualche imprecisato modo, comunque arriverà – ma in cuor nostro avremmo dovuto saperlo benissimo di non poterci aspettare altro che quello che è stato: portare fuori questa consapevolezza collettiva, senza star lì a pensare che ci bastino un paio di teste su un piatto d’argento, e provare a costruirci sopra qualcosa di buono, potrebbe essere un buon modo di affrontare questa sonora sconfitta.
E non parlo certo della sola Nazionale di calcio, perché non avrei il titolo per farlo. Parlo invece di un’Italia a cui, rispetto al 2006, non mancano solo le gambe (e la testa) dei propri calciatori, ma manca il cuore: il cuore vincente di una squadra coraggiosa, altruista e fantasiosa. Che appunto non è – non potrebbe essere – solo quella che parte per andare a giocare dall’altra parte del mondo, ma è piuttosto quella formata da milioni di persone che ogni giorno, con il loro lavoro, con le loro scelte, con il loro modo di affrontare la crisi sociale, economica e politica che in questi otto anni ci ha nel frattempo colpiti, definiscono l’identità italiana, il suo modo di stare nel mondo, di vergognarsi o di eccellere.
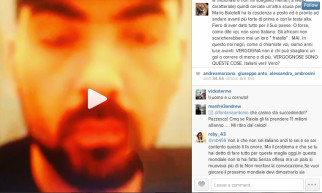 E allora anziché farci bastare il fatto di abbattere il capro espiatorio Prandelli (cosa che pure era necessaria), anziché accontentarci di dare dello “stronzo” a Balotelli (che pure se lo merita tutto e ci aiuta a guarire da un po’ di perbenismo superfluo), anziché consolarci affibbiando le colpe solo agli arbitri (che pure ne hanno, non foss’altro che per il cognome) e persino al clima subtropicale, chiediamoci cos’è cambiato dal 2006 a oggi?
E allora anziché farci bastare il fatto di abbattere il capro espiatorio Prandelli (cosa che pure era necessaria), anziché accontentarci di dare dello “stronzo” a Balotelli (che pure se lo merita tutto e ci aiuta a guarire da un po’ di perbenismo superfluo), anziché consolarci affibbiando le colpe solo agli arbitri (che pure ne hanno, non foss’altro che per il cognome) e persino al clima subtropicale, chiediamoci cos’è cambiato dal 2006 a oggi?
A cosa è dovuto questo drammatico “esaurimento della spinta propulsiva”? Da dove viene fuori questo “uomo solo” che al duro lavoro preferisce le presunzioni e i vezzi del fuoriclasse, e che alla fatica del confronto preferisce la fuga solitaria sull’autobus e persino nascondersi dietro una patetica ricerca di pietismo verso il suo essere “un negro africano”? Com’è possibile che preferiamo affidarci ad uno così – a mastini che abbaiano ma non mordono, anzi al massimo si fanno mordere e poi si allontanano con la coda tra le gambe – e perdere, senza accorgerci nemmeno che, perdendo, stiamo pagando anche la tentazione di rottamare i vecchi e di lasciare a casa i (bravi ma) piccoli?
Sì, ogni riferimento a fatti e persone rimasti in Italia non è puramente casuale.
Ma il fatto è che se questa Nazionale avesse avuto dietro la grande squadra di una Nazione, forse avremmo visto sul campo del Brasile qualche grande cuore in più e non ci sarebbe stato nemmeno bisogno delle grandi gambe del 2006 per scalare il Mondiale.
E se la Nazionale altro non è che il racconto di una Nazione, allora abbiamo davanti quattro anni (e anche la coincidenza temporale non sarà puramente casuale) per ribaltare questo senso della Patria all’incontrario di cui ci siamo ammalati ultimamente, imparando a smettere di cercare nelle grandi sfide la benedizione di una gloria personale e cominciando invece ad affrontarle chiedendoci quale contributo possiamo dare per vincerle, e per vincerle tutti insieme.
Se prima o poi impareremo che i (presunti) fuoriclasse non bastano senza una squadra – quella grande squadra coraggiosa, altruista e fantasiosa – magari non sarà ancora troppo tardi.






